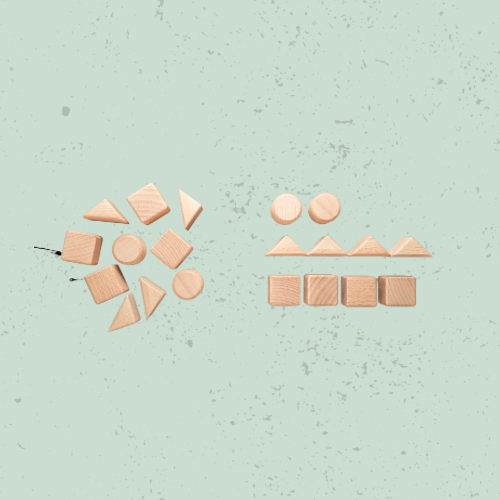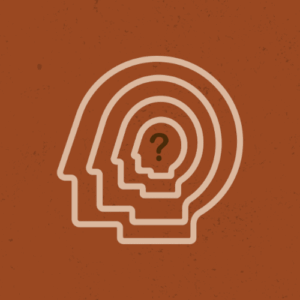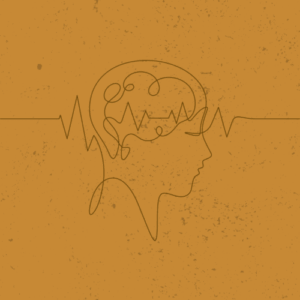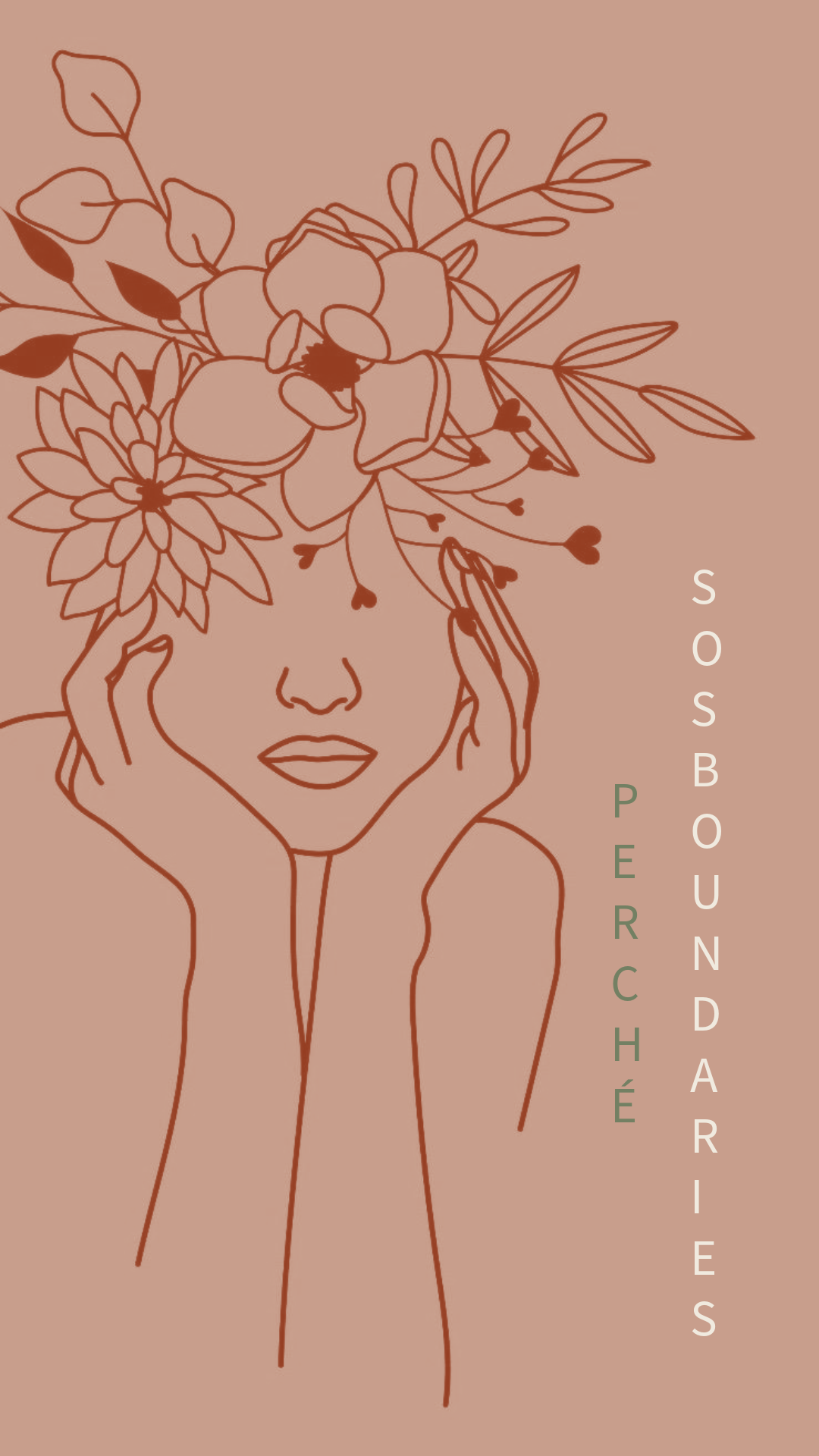Non tutti riescono a cogliere la complessità di chi hanno davanti. Alcuni vedono solo un lato, una funzione, un ruolo. Perché? Le neuroscienze ci offrono una spiegazione chiara: il cervello umano lavora semplificando la realtà, riducendola a etichette e categorie. Questo processo è utile per orientarsi, ma spesso ha un costo enorme: non vedere la ricchezza e le contraddizioni che rendono una persona davvero se stessa.
⸻
Il cervello e le etichette: perché semplifichiamo
Il nostro cervello ha un compito primario: risparmiare energia e reagire rapidamente.
Per farlo, utilizza scorciatoie cognitive (heuristics), schemi mentali e categorie. Studi sul funzionamento cerebrale (Kahneman, 2011; Bar, 2007) mostrano che il cervello classifica in automatico persone e situazioni: “affidabile/inaffidabile”, “forte/debole”, “introverso/estroverso”.
Questa tendenza a ridurre l’altro in etichette nasce da un meccanismo evolutivo: se posso riconoscere subito chi ho davanti, so più velocemente come reagire. Ma la velocità sacrifica la complessità. Non vedo l’intera persona, vedo solo l’etichetta che il mio cervello le ha appiccicato.
⸻
Quando qualcuno coglie la complessità
Non tutti si fermano a questa semplificazione. Ci sono persone che percepiscono le sfumature, che notano dettagli, contraddizioni, lati nascosti.
La ricerca sulla sensory processing sensitivity (Aron & Aron, 1997) mostra che chi ha una sensibilità più alta processa gli stimoli in modo più profondo: non si limita alla prima impressione, ma integra più segnali, più emozioni, più prospettive.
Questo permette di vedere la complessità degli altri. Non solo l’immagine in superficie, ma anche ciò che sta dietro.
⸻
Il vissuto di chi non viene visto
Ma cosa succede a chi nota la complessità degli altri, mentre la sua viene costantemente ignorata?
Queste persone vivono spesso un senso di solitudine sottile: vengono apprezzate per la loro empatia, per la loro capacità di capire, ma non sentono di essere ricambiate nello stesso modo.
Le emozioni più comuni in questo vissuto sono:
• frustrazione, perché la propria profondità non trova spazio;
• tristezza, per il sentirsi ridotti a un ruolo (“quella che aiuta”, “quello che capisce sempre”);
• senso di invisibilità, come se nessuno cogliesse il lato contraddittorio o vulnerabile che pure esiste.
⸻
Quando i confini si sfumano
Chi vive a lungo questa esperienza tende a proteggersi. I confini diventano più rigidi: ci si chiude, si mostrano solo alcuni lati di sé, quelli più “accettabili”.
Paradossalmente, questo porta a un adattamento: proprio chi percepisce la complessità degli altri smette di mostrare la propria, per paura di non essere compres*.
Ma questo meccanismo difensivo ha un costo:
• la perdita di autenticità,
• la fatica di sostenere un ruolo,
• il rischio di diventare invisibile proprio nelle parti più vere.
⸻
Chi vive in modo intenso
C’è un aspetto qui che merita attenzione.
Le persone che vivono in modo intenso non stanno mai nelle categorie. Non sono “solo questo” o “solo quello”: sono contraddittorie, cambiano, uniscono lati che agli altri sembrano inconciliabili.
E proprio per questo soffrono ancora di più quando vengono ridotte a un’etichetta.
Per chi sente in profondità e con intensità, non essere visto nella propria complessità è un dolore enorme. Significa sentirsi sempre “troppo” o “sbagliato”, come se ci fosse qualcosa da correggere per entrare nello stampo che gli altri hanno in mente.
Molte persone intense imparano allora a nascondere parti di sé, a limare i lati più scomodi, a mostrarsi in versione ridotta per non sentire il peso del giudizio. Ma dentro resta una frattura: il bisogno di autenticità non sparisce, e la tensione tra ciò che si è e ciò che si mostra diventa fonte costante di sofferenza.
⸻
Confini, sensibilità e trauma
Qui entra in gioco il tema dei confini emotivi. La sensibilità non è un problema di per sé: diventa vulnerabilità quando i confini sono fragili, o quando un trauma o un lutto non elaborato spingono a cancellare parti di sé per sopravvivere.
Senza confini chiari, la sensibilità diventa esposizione. Con confini più solidi, invece, diventa una risorsa: permette di vedere la complessità altrui senza perdersi.
⸻
Conclusione
Il cervello semplifica per proteggersi, ma alcune persone colgono le sfumature perché sentono di più. Chi vive questa condizione sa quanto sia difficile percepire la complessità degli altri e al tempo stesso non sentirsi mai completamente visto. È qui che i confini fanno la differenza: tra adattarsi e chiudersi, o restare centrati nella propria autenticità.
Questo è il cuore del mio progetto SOS Boundaries: lavorare con chi sente molto, con chi vive sensibilità e intensità come un peso, con chi porta traumi e perdite non elaborate che hanno lasciato i confini sfumati.
Perché la sensibilità non è un difetto: diventa risorsa solo se protetta da confini chiari.