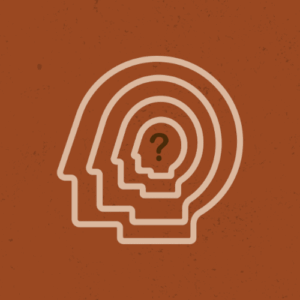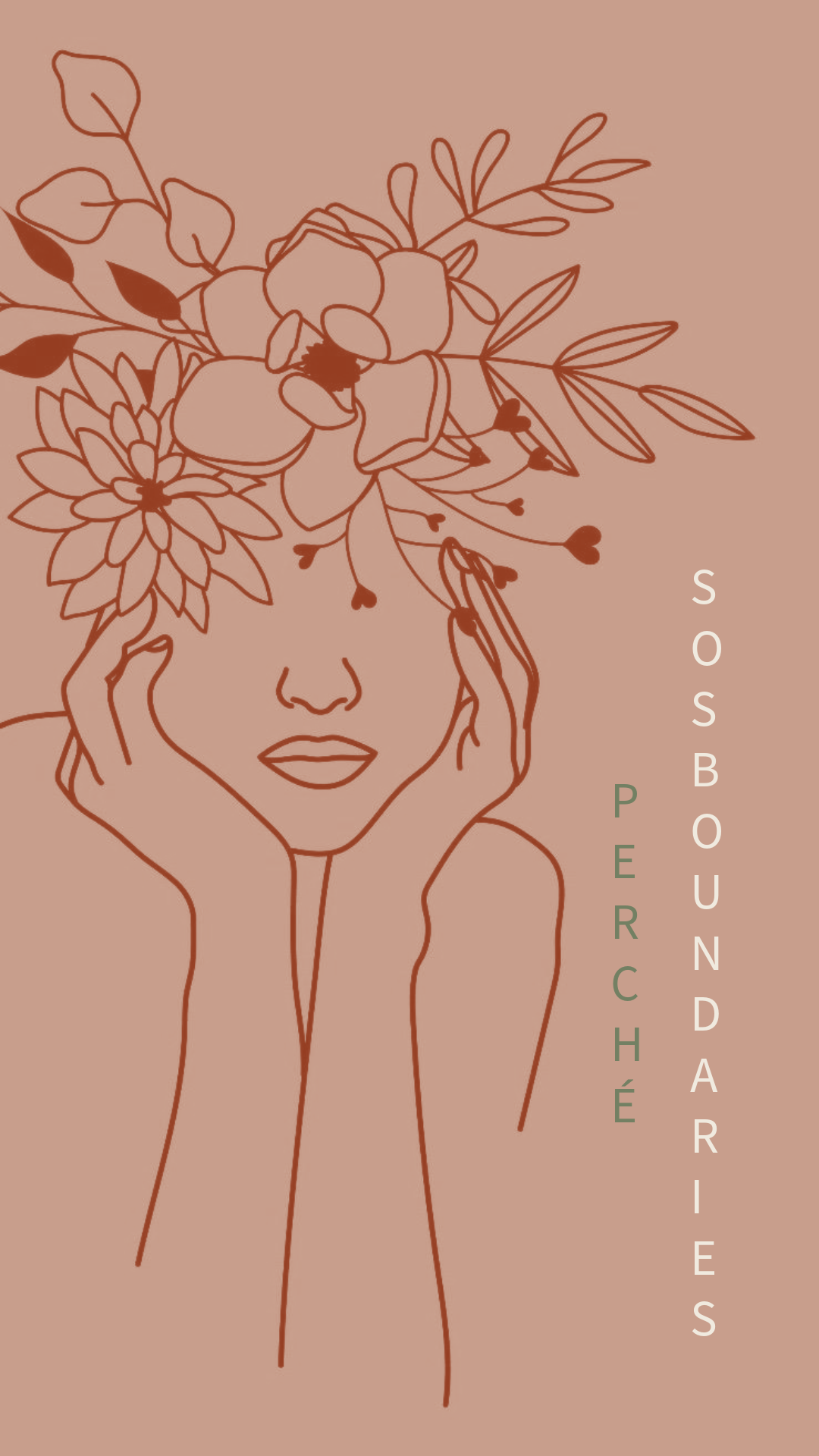I confini emotivi non sono muri o regole rigide: sono linee invisibili che ci aiutano a capire dove finiamo noi e dove iniziano gli altri. Ci permettono di regolare vicinanza, distanza e autenticità nelle relazioni.
Ma che cosa succede quando la nostra storia include un trauma o una perdita importante? Perché, dopo certe esperienze, diventa più difficile sentirci sicuri, dire “no” o aprirci senza paura?
Per rispondere, guardiamo il tema da quattro prospettive: la neuroscienza di Bessel van der Kolk, la teoria dell’attaccamento di John Bowlby, l’analisi culturale di Gabor Maté e le riflessioni comunicative di Paul Watzlawick.
⸻
1. Il corpo ricorda: il punto di vista di Bessel van der Kolk
Lo psichiatra Bessel van der Kolk ci mostra come il trauma non resti solo nella memoria cosciente: si imprime nel corpo e nel cervello.
Quando viviamo un evento travolgente — violenza, perdita, catastrofi emotive — il sistema nervoso registra la minaccia in modo profondo, oltre le parole.
Questo significa che, anche dopo anni, il corpo può reagire come se il pericolo fosse ancora presente. Non è questione di volontà: sono risposte automatiche, fisiologiche.
Ecco perché i confini emotivi diventano distorti:
• In iperattivazione (amigdala in allarme) ci chiudiamo dietro muri rigidi, pronti a difenderci da ogni contatto.
• In ipoattivazione o congelamento, i confini collassano: perdiamo il senso dei nostri bisogni, facciamo fatica a dire “no”, diventiamo troppo permeabili.
Van der Kolk nota un paradosso: molte persone traumatizzate si sentono “vive” solo quando rivivono il dolore originario. La familiarità con il pericolo rende la sicurezza estranea. Questo spiega perché, a volte, possiamo cercare inconsapevolmente situazioni che ripetono la ferita: solo lì il corpo percepisce intensità e presenza.
⸻
2. Attaccamento e confini: l’eredità di John Bowlby
John Bowlby, fondatore della teoria dell’attaccamento, sposta l’attenzione dal corpo alla relazione. L’attaccamento è il sistema con cui regolarizziamo vicinanza e distanza dalle persone significative.
Se, da bambini, viviamo cure prevedibili e accoglienti, sviluppiamo un modello interno stabile: possiamo avvicinarci e allontanarci senza perdere il senso di chi siamo. Su questo terreno crescono confini emotivi sani: “io sono io, tu sei tu”.
Quando invece le cure sono incoerenti, rifiutanti o spaventose, i modelli interni codificano il pericolo nella vicinanza o nell’assenza. Così i confini si organizzano in difesa:
• Stile ansioso: paura della separazione, confini troppo aperti; si monitora l’altro, si compiace, si fatica a dire “no”.
• Stile evitante: timore dell’intrusione, confini rigidi; si minimizzano i bisogni, si tengono le persone a distanza.
• Stile disorganizzato: avvicinamento e paura convivono; i confini oscillano, ora crollano, ora diventano invalicabili.
Nell’età adulta, queste mappe relazionali continuano a operare sotto stress: decidono chi lasciamo entrare, quanto, e quando chiudiamo la porta — spesso prima che la scelta diventi consapevole.
⸻
3. Cultura e autenticità: lo sguardo di Gabor Maté
Lo psichiatra Gabor Maté aggiunge un tassello importante: la cultura.
Nel libro The Myth of Normal sostiene che la nostra società premia produttività, compiacenza e sacrificio, mentre scoraggia vulnerabilità ed espressione autentica. Impariamo presto che dire “no” o mostrare i nostri limiti può sembrare egoista o debole.
Molti interiorizzano questo messaggio: per essere accettati bisogna soffocare i bisogni, adattarsi, cancellare i confini. Quello che nasce come strategia di sopravvivenza diventa un “modo normale” di vivere, anche se ci allontana dal sé.
Maté mostra, inoltre, come il crollo dei confini non è solo un problema relazionale: aumenta lo stress biologico e può danneggiare la salute. Reprimere continuamente rabbia, dolore o fatica logora il sistema nervoso e abbassa la capacità di riparazione.
Anche irrigidirsi non è la soluzione: muri troppo spessi impediscono intimità e connessione. Ma l’assenza di limiti espone il corpo a richieste e pressioni continue, senza difesa né cura.
⸻
4. Costrutti difensivi: il contributo di Paul Watzlawick
Paul Watzlawick porta l’attenzione su un altro livello: quello comunicativo e cognitivo. Secondo lui, le persone vivono spesso dentro “costrutti” rigidi, cornici linguistiche che definiscono la realtà e limitano ciò che percepiamo, interpretiamo e facciamo.
Applicato ai confini emotivi, questo significa che le strategie difensive nate da un trauma possono trasformarsi in regole interiori:
• “Devo sempre adattarmi.”
• “Non posso fidarmi di nessuno.”
• “Devo essere forte a ogni costo.”
Queste frasi non sono semplici pensieri: sono schemi che organizzano l’esperienza e mantengono vivo l’adattamento o il ritiro anche quando il pericolo originario è finito.
Watzlawick mette in evidenza anche il lato paradossale: cercare di risolvere un problema dentro lo stesso costrutto che lo crea spesso lo rende più stabile. Chi vive secondo il motto “devo essere sempre forte”, per esempio, può spingersi a negare la propria vulnerabilità, rinforzando così la solitudine che voleva evitare.
In questo senso, trauma e perdita non distorcono i confini solo attraverso il corpo, le relazioni o la cultura, ma anche a livello cognitivo: i costrutti difensivi diventano piccole prigioni linguistiche, mantenute dagli stessi meccanismi che un tempo offrivano protezione.
⸻
Conclusione
Trauma e perdita possono piegare i confini emotivi in due direzioni opposte: rigidità che esclude o permeabilità che annulla. Il corpo, le relazioni, la cultura e persino i nostri costrutti mentali partecipano a questo processo.
Comprendere questi livelli aiuta a vedere i confini non come muri, ma come soglie dinamiche, da riconoscere e allenare con consapevolezza.
Se senti che i tuoi confini sono diventati troppo rigidi o troppo fragili, o se dopo un trauma o una perdita fai fatica a sentirti autentico, sappi che non devi farcela da solo. SOS Boundaries è il progetto che ho creato per accompagnare chi vuole ritrovare spazio, sicurezza e presenza nelle relazioni con sé e con gli altri.
Se hai bisogno di supporto su questo percorso, puoi contattarmi: il primo spazio di ascolto è gratuito.