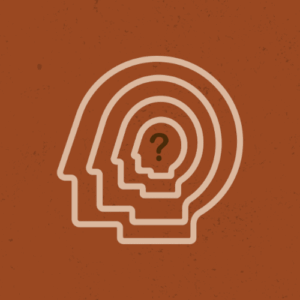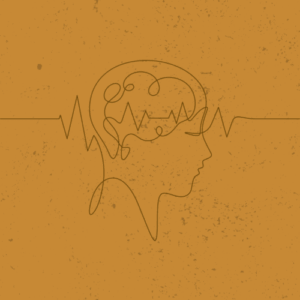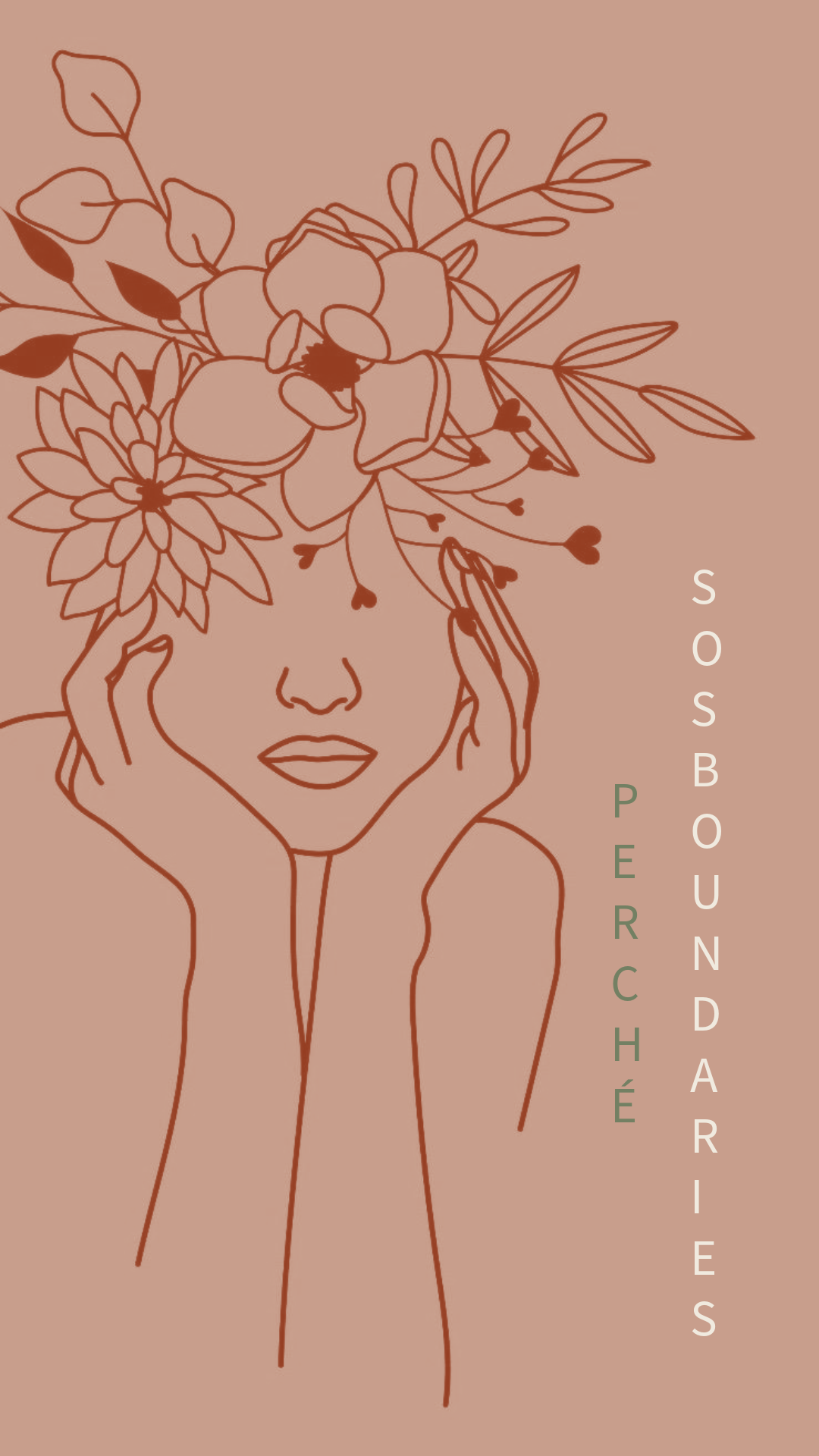In un mondo che misura tutto in velocità, risultati e resistenza, la sensibilità è diventata un problema da risolvere.
Eppure, per secoli, chi sentiva di più aveva un ruolo: era la persona che vedeva prima, che collegava, che portava senso.
Oggi, chi è empatico o autentico viene spesso percepito come ingenuo, fragile o “fuori luogo”.
Ma non è la sensibilità a essere cambiata: è il mondo intorno a noi.
La nascita di un mondo che ha smesso di sentire
Se oggi chi è sensibile o autentico si sente “fuori posto”, non è un caso.
È il risultato di una trasformazione culturale lunga secoli, iniziata con l’industrializzazione.
Fino all’Ottocento, la vita era scandita dai ritmi naturali e dalle relazioni dirette: la comunità, la famiglia, il lavoro artigiano. L’essere umano valeva per quello che era, non per quello che produceva.
Poi arrivò la rivoluzione industriale, e con essa una nuova logica: il tempo è denaro.
Il valore delle persone iniziò a misurarsi in efficienza, velocità, prestazione.
Chi era riflessivo diventò “lento”. Chi era empatico, “troppo emotivo”.
Il modello vincente era l’individuo funzionale, produttivo, sempre concentrato sul risultato.
Nelle fabbriche, e poi negli uffici, l’emozione non serviva. Serviva resistere.
Il corpo e la mente vennero trattati come strumenti di lavoro. La scuola, il sistema economico, perfino la medicina si sono modellati su questa visione: correggere, ottimizzare, eliminare ciò che “intralcia”.
Così la sensibilità ha perso status sociale.
Da segnale di profondità è diventata una debolezza da mascherare.
E ancora oggi, in molte culture del lavoro e della scuola, un bambino che piange troppo o un adulto che “si fa coinvolgere” è visto come problematico, non come una persona che sente davvero.
⸻
Le radici familiari: la generazione che doveva sopravvivere
Per capire da dove arriva questo disprezzo per il sentire, bisogna guardare alle generazioni prima di noi.
Chi è cresciuto durante o subito dopo le guerre mondiali non poteva permettersi di fermarsi sulle emozioni.
Il mondo era instabile, violento, segnato da fame, perdita, paura.
La priorità era sopravvivere, non capire cosa si provava.
In quei contesti, la vulnerabilità era pericolosa.
Un bambino troppo sensibile rischiava di essere sopraffatto; un adulto troppo empatico rischiava di non farcela.
La regola era: “Non pensare, fai. Non sentire, resisti.”
Molti genitori e nonni hanno interiorizzato questa logica.
Non perché fossero freddi, ma perché era l’unico modo per andare avanti.
Chi tornava dalla guerra o dalla povertà portava con sé un trauma collettivo: un bisogno profondo di controllo, stabilità, silenzio.
La psicologia transgenerazionale spiega bene come queste esperienze si trasmettono.
Non serve parlarne per ereditarle: il corpo, il tono di voce, le reazioni emotive di chi ci cresce accanto modellano il nostro sistema nervoso.
Quando un genitore ci dice “Non fare così, non piangere, non ti agitare”, spesso sta cercando di proteggerci da un mondo che per lui è stato pericoloso.
Ma dentro di noi resta un messaggio implicito: “Se sento troppo, sbaglio.”
E così, anche senza guerre, molti di noi vivono ancora come se la sensibilità fosse un rischio da contenere.
Il risultato? Intere generazioni che sanno fare, ma non sanno sentire.
Che sanno adattarsi, ma non riconoscersi.
⸻
Quando la sensibilità era un valore
Eppure non è sempre stato così.
Se guardiamo più indietro, nelle società tradizionali o preindustriali, la sensibilità non solo era accettata — era rispettata.
Ogni comunità aveva figure che vivevano in ascolto profondo:
chi osservava la natura, chi interpretava i sogni, chi coglieva segnali invisibili agli altri.
Lo sciamano, il guaritore, il poeta, il saggio: persone con una percezione più fine della realtà, che usavano la loro sensibilità per orientare, connettere, proteggere.
La loro forza non era la produttività, ma la capacità di leggere il senso delle cose.
In quelle culture, sentire molto non significava essere fragili, ma essere più in contatto con ciò che esiste.
Era un tipo di intelligenza emotiva e simbolica, indispensabile alla sopravvivenza collettiva.
Anche in Occidente, prima che la scienza separasse ragione e sentimento, molti pensatori univano sensibilità e riflessione.
Socrate, Platone, Eraclito — non erano “razionali” nel senso moderno. Erano mossi da domande, dubbi, empatia verso la condizione umana.
La filosofia nasce da un atto sensibile: il bisogno di capire perché soffriamo, amiamo, cerchiamo giustizia.
Poi, con la logica industriale e il pensiero meccanicistico, questa forma di intelligenza è stata ridotta a debolezza.
Il corpo è diventato macchina, l’emozione un disturbo da regolare.
Eppure, se guardiamo alla storia lunga dell’umanità, è la sensibilità che ha permesso la cooperazione, la cura e la cultura.
Non è mai stata un errore evolutivo. È stata, piuttosto, la condizione che ci ha resi umani.
⸻
Conclusione
Chi oggi si sente “troppo sensibile” o “troppo autentico” non è fuori posto.
È semplicemente nato in un’epoca che ha dimenticato quanto la sensibilità serva per vivere, non solo per capire.
Non c’è nulla di sbagliato nel sentire troppo.
C’è solo una società che, da troppo tempo, ha paura di farlo.
![]()