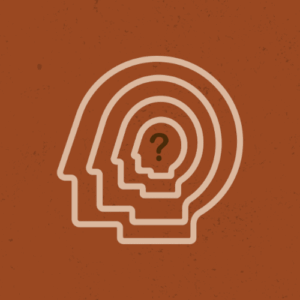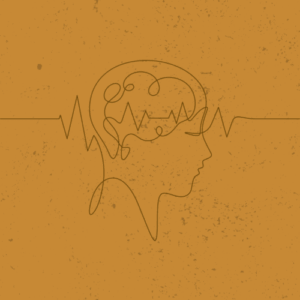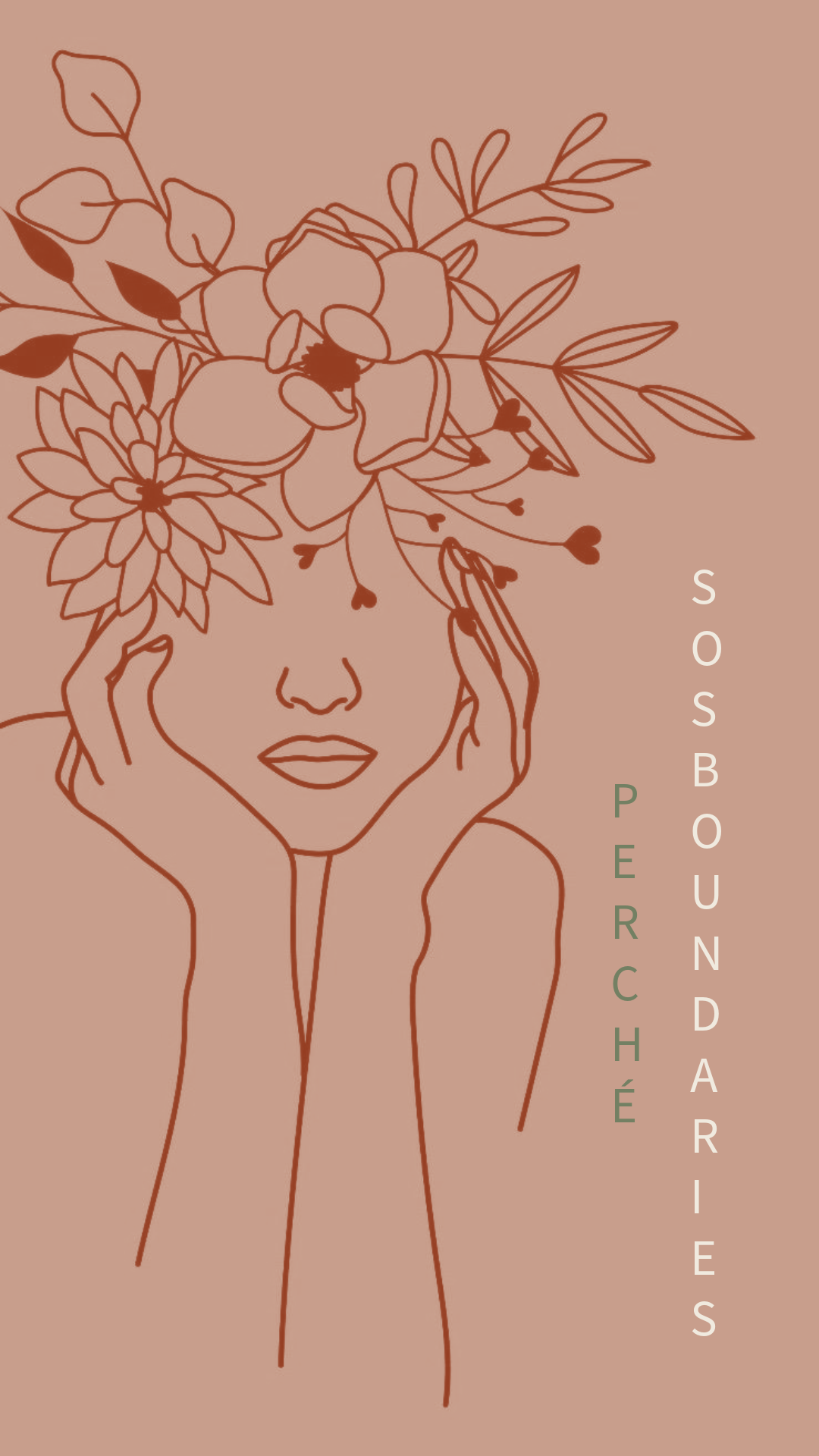Per più di dieci anni ho cambiato terapeuti, consulenti, e a un certo punto sono passata anche alla psichiatria. Non riuscivo a capire quale fosse il mio problema. O forse, il problema era che nessuno lo capiva davvero.
Mi sentivo una persona difficile da decifrare: troppo pensante, troppo emotiva, troppo “tutto”. Ogni volta ricevevo una diagnosi diversa — depressione, ansia, e una volta persino “disturbo borderline ad alto funzionamento”.
Ma nessuno centrava davvero il punto.
Io non cercavo stabilità, cercavo intensità.
Per me l’intensità era vita, verità, movimento. Per loro, era disfunzione.
⸻
Quando la psicologia guarda solo alla media
Con il tempo ho capito che il problema non era “la mia mente”, ma il modo in cui veniva interpretata.
La psicologia tradizionale si basa su modelli statistici: osserva cosa è comune e considera tutto il resto una deviazione. Le diagnosi servono per descrivere pattern che si allontanano dalla norma. Ma se quella norma è costruita sulla media, tutto ciò che è più profondo, più rapido, più sensibile o più intenso finisce per sembrare patologico.
Il concetto di “funzionalità” è relativo. Dipende dal contesto sociale, culturale, persino economico. Una persona può essere perfettamente “funzionale” in un sistema creativo e libera in un sistema che la valorizza, ma “problematicə” in un contesto che richiede adattamento rigido e conformità.
E io, con la mia mente sempre accesa e il mio modo diverso di percepire, ero troppo fuori statistica per essere compresa.
⸻
Il paradosso di chi sente troppo e pensa troppo
Negli anni, la mia domanda è sempre stata la stessa: sono io o sono loro?
Sentivo dentro qualcosa di enorme, di complesso, ma non trovavo intorno un linguaggio che lo riconoscesse. Tutti mi dicevano che dovevo imparare a calmarmi, a ridurre, a semplificare.
Ma per me non era questione di ridurre: era questione di capire.
Solo più tardi ho scoperto che esistevano parole scientifiche per descrivere tutto questo.
Parole che in dieci anni di psicoterapia nessuno aveva mai pronunciato.
Neanche studiando psicologia le avevo incontrate.
Le ho trovate solo anni dopo, durante l’accademia di counseling, quando un professore mi ha parlato di mente multidimensionale, di rainforest mind, di alta sensibilità e alta intensità.
Quel giorno ho sentito qualcosa cambiare. Per la prima volta, qualcuno parlava la mia lingua.
⸻
La base scientifica che nessuno mi aveva spiegato
Questi concetti non nascono dal nulla.
La ricerca di Elaine Aron sull’High Sensitivity ha mostrato che circa il 20% delle persone possiede un sistema nervoso più reattivo agli stimoli esterni e interni.
Il neuropsichiatra Kazimierz Dabrowski ha parlato di Overexcitability: intensità emotiva, sensoriale, intellettuale, immaginativa e psicomotoria.
Altri studi collegano la cosiddetta “mente multidimensionale” o “rainforest mind” a un modo di processare la realtà su più livelli contemporaneamente.
In parole semplici: non è una malattia, è un diverso modo di funzionare.
Il problema è che pochi professionisti sono formati per riconoscerlo.
Così, la persona ad alta sensibilità o intensità finisce per sentirsi disfunzionale, semplicemente perché non rispecchia il modello medio.
⸻
Ansia e depressione non erano la causa, ma la conseguenza
Guardando indietro, oggi mi è chiaro che l’ansia e la depressione non erano il mio problema originario. Erano il risultato del vivere per anni in un sistema che non aveva spazio per me.
Quando il proprio modo di sentire e pensare viene invalidato o interpretato come un difetto, il corpo e la mente si difendono.
Il cervello di una persona altamente sensibile o intensa si sovraccarica facilmente: il sistema nervoso resta in uno stato di allerta costante, la mente non trova rispecchiamento, e il senso di solitudine cresce.
Da qui, la spirale dell’ansia e della depressione.
Non perché si è malati, ma perché si è non riconosciuti.
⸻
Perché molti terapeuti non lo vedono
Non è colpa loro.
La maggior parte delle formazioni universitarie e cliniche si concentra su categorie diagnostiche: ansia, depressione, trauma, disturbi di personalità.
Sono modelli utili, ma parziali.
Manca ancora un linguaggio condiviso per parlare delle differenze qualitative del funzionamento mentale, non solo quantitative.
Chi non ha vissuto personalmente o studiato in profondità queste esperienze non le riconosce. E chi non ha gli strumenti tende a ricondurle a ciò che conosce: disfunzione, disregolazione, instabilità.
Ma una mente intensa non è instabile. È una mente che funziona su più canali contemporaneamente, e che ha bisogno di spazi adeguati per esprimersi, non di gabbie teoriche.
⸻
Il punto di svolta: essere vista, non aggiustata
Durante i miei studi di counseling, quando ho sentito per la prima volta quei concetti, ho provato una cosa nuova: sollievo.
Non perché qualcuno mi avesse dato una nuova etichetta, ma perché finalmente qualcuno mi vedeva.
Non c’era niente da curare. C’era solo da capire.
Da quel momento ho smesso di cercare di “funzionare come gli altri”.
Ho iniziato a chiedermi invece: come posso funzionare bene, nel mio modo?
Questo ha cambiato tutto.
⸻
Verso un linguaggio più ampio della mente umana
Non serve negare la psicologia tradizionale. Serve ampliarla.
Serve un linguaggio che includa anche le menti ad alta sensibilità e alta intensità, che oggi restano spesso ai margini dei modelli clinici.
Serve un approccio che veda la persona intera — non solo i sintomi — e che capisca come la mente reagisce quando non trova un contesto in cui rispecchiarsi.
Perché non tutte le sofferenze sono segni di malattia.
A volte sono la conseguenza di un linguaggio troppo stretto per contenere chi siamo davvero.
⸻
Conclusione
Se anche tu ti sei sentitə “troppo” — troppo emotivə, troppo pensante, troppo intensa — forse non sei tu il problema.
Forse è solo che nessuno ti ha mai spiegato come funziona davvero la tua mente.
Non hai bisogno di essere normalizzatə.
Hai bisogno di essere compresə.
E da lì, finalmente, di costruire un modo tuo di stare bene.